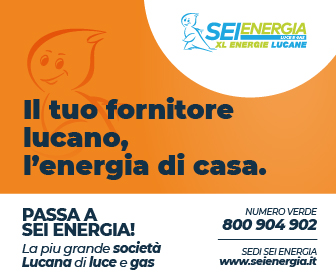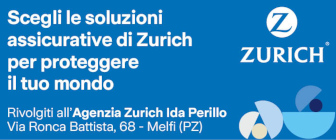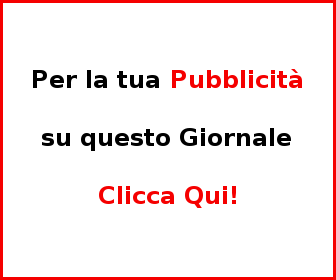È degli ultimi giorni la notizia della pubblicazione scientifica su una prestigiosa rivista (Archeologia e Calcolatori, All’insegna del Giglio, N. 36.1 – 2025) dell’articolo dal titolo: “Viarium, paesaggi culturali nell’Ager Bantinus. Un esperimento di archeologia pubblica nell’Alto Bradano”, nel quale vengono esposti i risultati delle campagne di scavo e delle iniziative di valorizzazione intraprese dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata con la funzionaria archeologa Sabrina Mutino, in collaborazione con Mario Saluzzi già conservatore Pinacoteca Camillo D’Errico e la società pugliese Techné.
Per dare ragione delle novità intercorse durante le campagne di scavo che progressivamente hanno inciso sulla conoscenza storico-archeologica del territorio e per trasferire questa conoscenza anche a un pubblico di non specialisti, è stato realizzato il docufilm “Viarium. Paesaggi culturali nell’Ager Bantinus” (https://youtu.be/ccXt9GhQy1Y?si=54tO3JoMdqgbBUXt ). Viarium, inteso come itinerario, come dominio di appartenenza, lungo le vie della Lucania interna (viarium, forma neutra dell’aggettivo viarius, letteralmente delle strade, o delle vie).
Il viaggio virtuale tra le scoperte archeologiche lungo le vie dell’Ager Bantinus è punteggiato da una serie diversificata di evidenze archeologiche, in cui le informazioni di scavo, limitate dalle circostanze del cantiere “di emergenza”, hanno permesso di ricostruire un’esperienza significativa di archeologia pubblica.
Gli esiti delle ricostruzioni rappresentano la forma “narrata” dei ritrovamenti lungo la via del Bradano-Basento, non solo sotto sotto il profilo storico e archeologico, ma anche sociale e culturale, perché descrivono la fisionomia di un territorio da sempre ambito per le sue risorse naturali. Un territorio che ha saputo accogliere e dare sostentamento per millenni a diverse civiltà.
Popolazioni che hanno tracciato vie e lasciato dei segni oggi in parte ritrovati dagli scavi.
Il filmato vuole dare sostanza visiva ad una serie molto nutrita di ritrovamenti, alcuni con evidenze ben definite, ricostruibili con i metodi del criterio filologico, altri con caratteristiche solo accennate, con segni inequivocabili di una presenza umana.
Per tutti questi contesti è stata offerta una lettura possibile, che rimarca non tanto gli aspetti di dettaglio, non ricostruibili in modo rigoroso per assenza di dati sufficienti, ma la grande eterogeneità di informazioni, utili per tracciare un percorso nello spazio e nel tempo.
L’impatto di questo storytelling sulle comunità territoriali ha attivato una reazione emotiva dirompente.
Grazie ai canali di comunicazione attivati da Mario Saluzzi oggi Presidente del Centro Studi Manfredi di Svevia, è stato sorprendente scoprire le aspettative, nei confronti del potenziale archeologico, degli abitanti di quei luoghi, che pagavano lo scotto di aver vissuto all’ombra della più celebre Venosa.
In letteratura quello di Palazzo San Gervasio era menzionato solo come territorio tra Bantia e Venusia.
È stato merito della ricerca storico-archivistica l’aver fornito, inizialmente, le basi per una rilettura della storia locale e, successivamente, della ricerca archeologica l’aver documentato le tracce evidenti di una lunga frequentazione umana.
Il progetto di valorizzazione avviato dall’attivazione di queste sinergie intende mettere a sistema tutti questi ritrovamenti, con la costruzione di percorsi turistico-culturali finalizzati alla conservazione e alla tutela, ma anche alla nascita di opportunità che generino ricadute in termini economici sul territorio.