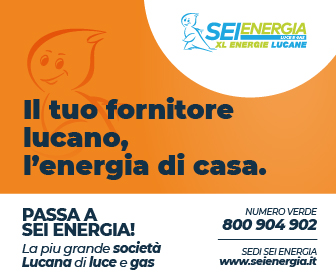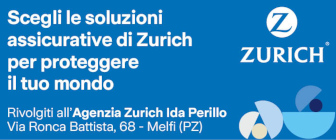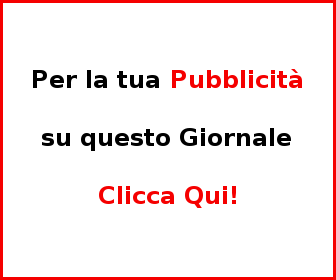Un folto e attento pubblico ha preso parte, nell’Atrio del Palazzo Vescovile di Melfi, alla lezione-spettacolo “L’alba del secolo novo”, l’Italia di inizio Novecento tra storia, arte e musica, svoltasi nell’ambito del ciclo “Lezioni d’estate”, consigli per l’estate promosso e organizzato dall’Associazione e dalla Fondazione “Francesco Saverio Nitti”.
L’evento, patrocinato dal comune di Melfi con il contributo di Bbc Gaudiano di Lavello, ristoranti “Jeans” e “Sole di Mezzanotte”, è rientrato anche nelle iniziative di SuperScienceMe, notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l’innovazione umanistica, scientifica e sociale (Diuss) dell’Università degli Studi della Basilicata.
Introdotto da Gianluca Tartaglia, direttore dell’Associazione Nitti, nella lezione-spettacolo le tre voci dello storico Donato Verrastro, del musicologo Pier Paolo De Martino e della storica dell’arte Mariadelaide Cuozzo, si sono intrecciate per rievocare gli scenari di un’epoca affascinante e contraddittoria: la cosiddetta Belle époque.
I relatori hanno catturato per due ore l’attenzione del pubblico grazie al racconto storico e alla proiezione di immagini di opere d’arte, documenti fotografici, musicali e filmici riferiti a un periodo irripetibile, contrassegnato da innovazioni scientifiche e tecnologiche, dall’affermazione della società di massa e dell’industria culturale, dalla diffusione del gusto Art nouveau e dall’irrompere delle avanguardie artistiche. Un’epoca che, tuttavia, fu anche attraversata da lotte sociali e conflittualità destinate a deflagrare nella Grande Guerra.
Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università degli Studi della Basilicata, ha tracciato un percorso partito dall’Esposizione Universale di Parigi del 1900 e dal diffondersi in tutta Europa e negli Stati Uniti del nuovo stile Modernista, che caratterizzò l’arte urbana delle architetture, delle metropolitane, dei Grandi Magazzini e della grafica pubblicitaria, allora nell’epoca del suo massimo splendore grazie all’opera di straordinari artisti del cartellone.
Un gusto internazionale diffuso anche in Italia, che si affermò presso la borghesia soprattutto attraverso i moltissimi oggetti di arte applicata che si riversarono sul mercato, portando la bellezza nelle case e nella vita quotidiana, dalle suppellettili all’abbigliamento, dai gioielli ai mobili.
Sul versante opposto, il realismo sociale denunciava i lati oscuri del sistema capitalistico, mentre i nuovi linguaggi delle avanguardie segnavano una frattura con il pubblico borghese, rompendo tutte le regole e gli schemi estetici consueti e spesso utilizzando l’arte anche come strumento politico, come nel caso dei Futuristi che si schierarono a favore dell’intervento dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale.
Pier Paolo De Martino, musicologo, già docente di Storia della Musica all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha delineato il quadro musicale europeo all’inizio del Novecento, mettendo in rilievo la relativa omogeneità di una cultura nella quale coesistevano tradizioni nazionali diverse, dando luogo a un repertorio diffuso nelle sale da concerto e nei teatri di tutte le maggiori città del vecchio continente.
All’interno di tale contesto l’Italia conservava un’identità forte, legata alla tradizione operistica e alle canzoni napoletane, grazie anche al ruolo di cantanti celebri come Enrico Caruso, il cui ruolo fu decisivo nel decollo dell’industria discografica.
All’ombra degli ultimi grandi successi prodotti da Puccini e dagli altri compositori della cosiddetta “Giovane scuola”, andavano tuttavia emergendo fermenti e nuove tendenze che avrebbero successivamente introdotto significativi elementi di discontinuità rispetto alla gloriosa tradizione del melodramma.
Donato Verrastro, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi della Basilicata, ha messo in luce le significative trasformazioni che hanno segnato il passaggio tra Otto e Novecento e il consolidarsi, in tutto l’occidente, di un diffuso clima di fiducia.
La nascita della società di massa si accompagnava allo sviluppo delle scienze positive e della tecnica, all’avvento dell’industria, al miglioramento delle condizioni di vita, alla conseguente crescita della popolazione mondiale e all’affermarsi dell’economia di mercato.
Ma è stata l’occasione anche per cogliere le contraddizioni che il nuovo corso imponeva, come la questione meridionale, la grande emigrazione e il progressivo radicamento della competizione mondiale sotto le spinte imperialiste e coloniali.
Il liberalismo e la democrazia, che avevano sostenuto gli itinerari di crescita, si sarebbero poi infranti con la crisi di un’epoca che la Grande guerra
avrebbe contribuito ad accelerare.
All’evento culturale hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente del consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino, l’assessore al Bilancio Sandro Panico e il Vescovo della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa, S.E. Ciro Fanelli che ha concluso l’apprezzata lezione-spettacolo seguita, con attenzione e interesse, dal numeroso pubblico.